di Francesca Andreini Galanti
 VIA
VIA
Gli altri viaggiatori guardano gli orologi, consultano i tabelloni e si avviano in fretta, stringendo le mani sui manici delle valige. Alcuni, in transito, se ne stanno sulle poltroncine a sbriciolare merende e stanchezza fra gomitoli di bagagli, braccia riverse, riviste e frignate di bimbi. Il caldo di Fiumicino ha seguito tutti fin dentro l’aeroporto, nascosto fra i vestiti leggeri, e adesso trasuda da ogni gesto.
Aleggia anche su noi cinque, che occupiamo tutta una fila di questi sedili che odorano di viaggi. I grandi ingioiellati di borse e tracolle. I ragazzi incastrati dentro strati di abiti per ogni temperatura. Un po’ pallidi, un po’ stropicciati da una primavera indaffarata, ce ne stiamo immobili, stringendoci addosso le cose indispensabili come computer portatili, contratti, prenotazioni e orsetti del cuore. Il solito minitrasloco che vola con noi ad ogni trasferimento.
La figlia più piccola mi guarda, arrossata.
“Mamma, posso togliere almeno il gilè?”.
“E dove lo mettiamo? Un po’ di pazienza su, che tra poco partiamo. Ecco, magari se sposto questo stai meglio…” le rispondo aggiustando il borsone fra di noi.
“Quanto hanno?” chiede, indicando i ragazzi, la signora minuta seduta di fronte.
“Cinque, dieci e tredici” sorrido io.
“Un bell’impegno viaggiare così, eh?”.
Stringo le spalle a indicare che ci siamo abituati. La signora guarda un po’ spaventata la quantità di prole e di oggetti che ci segue. Chissà che faccia avrebbe fatto se ci avesse visto qualche anno fa, quando giravamo con due passeggini e il più piccolo al guinzaglio. O anche solo pochi minuti prima, quando c’era anche il gatto nella gabbia, che guardava dritto con gli occhi sbarrati, rigurgitando dalla gola un suono profondo e disperato.
L’abbiamo dovuto tirare fuori dalla gabbia per farlo passare dallo scanner e rimettere dentro fra grida di panico, graffi, tentativi di fuga e imprecazioni.
Lui ora se ne sta buttato in chissà quale deposito, nel reparto dei bagagli speciali. E noi seduti qui. Fermi.
“Perché dobbiamo partire?” chiede il piccolo. Di nuovo.
“Perché è divertente,” ripeto “perché a papà hanno proposto un bel lavoro, e potremo fare tante cose nuove…”.
Perché sono finiti i soldi, amore mio. Perché è passato un periodo lungo cinque anni in cui mi sono succhiata Roma con le sue luci e le sue frenesie. Roma come un biberon di rumori e caos, calore e giornate vibranti. Perché le notti le passavo a scrivere e ingoiare sonno come ossigeno raro. Perché i mille impegni hanno tracciato i percorsi di noi genitori come due sentieri ripidi e distanti da cui non abbiamo potuto staccare lo sguardo.
E ora è arrivato il momento di inventarci di nuovo un cammino insieme.
L’aeroporto si muove intorno, con i trambusti degli altri.
I ragazzi stirano la stanchezza fuori da ogni muscolo.
“E ora, che si fa?” chiede la sorella grande.
“Aspettiamo, non c’è altro da fare…”.
Noi genitori stringiamo le nocche delle mani, graffiate, le une alle altre e guardiamo avanti, come gatti perplessi.
Abbiamo passato settimane a salutare amici, maestri e parenti, a disdire allacciamenti, abbonamenti, impegni. Spostare utenze, chiudere conti. Abbiamo iniziato con calma, per tempo, siamo tipi previdenti e non è mica la prima volta che cambiamo paese. Iniziamo con calma, ci siamo detti, e facciamo tutto per bene. Eppure. Le ultime settimane come sempre ci siamo trovati a scoprire cose non fatte, a porre rimedio, a correre e telefonare.
Come un derviscio che si avvolge in un crescendo di spire, come uno stregone alle prime armi che non sa più fermare l’incantesimo evocato, abbiamo gettato la nostra vita in un vortice che ci strappava di dosso le abitudini, le certezze e le costruzioni degli ultimi anni, in un moto sempre più frenetico. E così, maghi e danzatori esagitati, ci siamo storditi di incombenze, per settimane, lanciandoci senza ripensamenti in questa corsa verso il nuovo.
Fino a questo aeroporto, fino a questa mattina. Fino a queste poltroncine odorose che sono come l’occhio del ciclone, dove tutto è fermo e piatto.
Adesso possiamo riposare, possiamo stringerci le mani e aspettare.
Possiamo osservare l’uragano da noi stessi provocato che continua a vorticarci intorno, scagliando tutto lontano.
Una faccia amica, un luogo frequentato per anni, l’odore di un abbraccio, la fontana all’angolo della strada, i piccioni che tuffano la testa, la ghiaia sotto i piedi, le foglie che hanno visto cambiare le stagioni, le aiuole del parco, i giochi compagni dei bambini, i ricci dell’amichetto che saluta senza sorridere, “davvero andate via?”…
Tutto gira e si allontana; la nostra vita di prima sparisce veloce in una nebbia indistinta.
Distogliamo l’attenzione, la lasciamo vagare su qualche rivista e sul via vai intorno, su giornalini e giocattoli ciancicati senza convinzione. Noi grandi facciamo gli ultimi controlli dei biglietti, verifichiamo i documenti, rispondiamo agli ultimi saluti di amici e colleghi.
Vedo sul display un numero che mi fa trasalire. Rispondo dopo un respiro.
Che bello sentirti, certo che sono felice di partire. Certo che mi dispiace.
“Vai in un bel posto, troverai senz’altro qualcosa di interessante da fare. Peccato, però, perché facevamo un’ottima squadra, insieme…”.
Mentre ripongo il telefono vedo l’epilogo di due anni di lavoro che si sfalda fra le mie mani, sfugge alla presa e vola via veloce, dentro l’uragano, insieme a tutto il resto.
Non vedrò la fine, altri termineranno il progetto. Ho corso come un bambino che gioca a perdifiato, e ora che il mio aquilone vola alto devo aprire le mani, devo lasciarlo andare…
“I passeggeri con destinazione Washington sono pregati di avviarsi all’imbarco”.
Finalmente.
“Ragazzi, prendete le vostre cose”.
Ognuno di noi raccoglie i suoi troppi bagagli.
“Abbiamo tutto? Sicuri?”.
Sotto i chili eccessivi, tutti insieme camminiamo come papere ubriache verso il gate. Superiamo il banco della compagnia aerea e imbocchiamo il finger. Il piccolo mi tira per la manica.
“Mamma?”.
Sposto di lato uno zaino per guardarlo meglio.
“Si, amore?”.
“Il mio pesce si troverà bene nella fontana della tua amica?”.
Gli sorrido.
“Ma certo… si divertirà come un pazzo!”.
Mi volto verso le ragazze e vedo che ci ascoltano attente, senza dire niente, e sorrido anche a loro.
Mentre sfiliamo sotto l’accoglienza rituale dell’equipaggio colgo lo sguardo di mio marito. Che ogni qualche anno ci porta a vivere lontano e adesso mi guarda, di sfuggita, cercando di capire se anche questa volta sono veramente in vena di sorrisi.
Sull’aereo, poi, scaricati i pesi e allacciate le cinture, ognuno pisola e si gusta in solitudine il proprio distacco.
Io, a occhi chiusi, penso agli oggetti, alle facce, alle stanze e alle impressioni che, di colpo, sono diventati passato. Mi aleggiano intorno come un fantasma caro, che non si decide a volare nel niente.
Il legno del pavimento impregnato di quello che abbiamo cucinato, di come ci abbiamo giocato, degli animali che ci hanno zampettato sopra e dei bebè che ci hanno vomitato… Questa mistura speciale è ancora lì dove l’abbiamo lasciata, poche ore fa, eppure è già lontana da noi. È già passato.
Chissà come sta il gatto? Chiuso in gabbia, miagolerà disperato, ma tanto nessuno lo sente perché è riposto nella stiva, come un carico qualsiasi. E poi lui non ha nessun presente lontano con cui fare i conti. Lui, anzi lei, perché è una gatta, il suo presente se lo porta a spasso in ogni istante di vita e non deve preoccuparsi di metterlo in prospettiva, in relazione, di spiegarselo o di aspettarselo in alcun modo. Sta nella stiva e soffre, stipata fra rumori e mancanza di ossigeno, col suo presente di carico qualsiasi.
Poco dopo siamo in quota. Inizia il via vai dei carrellini che emanano odori arroventati. Inizia il rito delle domande standard e delle braccia che porgono.
Beviamo vino e coca cola, apriamo le vaschette bollenti.
“Non sembra male, ragazzi…”.
E poi infiliamo le cuffie, ci sintonizziamo tutti sulla televisione minuscola davanti a noi. Pare ne vada della vita, di vedere tutto quello che c’è da vedere e di mangiare tutto quello che c’è da mangiare.
Ognuno con dietro gli occhi le fragranze lontane, le luci e le facce che ha lasciato.
“Faremo tante cose, in America” raccontiamo noi genitori, fra un film e un pasto, ai ragazzi.
Raccontiamo quello che il presente ormai lontano ci suggerisce per il futuro: una vita altrettanto distante e invisibile, per il momento, e così sconosciuta da sembrare impossibile; ma che invece, un giorno, ci sarà.
“Non ci saranno le solite cose, ma ci saranno viaggi e avventure. Non ci sarà Roma, ma ci saranno città enormi, e grattacieli altissimi. E poi ci sarà gente diversa, invece delle facce solite”.
Gente di tutti i colori e gente strana, che nessuno si gira a guardarla perché in America è così, puoi essere come vuoi. Puoi fare quello che vuoi. Puoi dire quello che pensi. Nessuno si stupisce di niente e se si stupisce lo tiene per sé. Intanto ti saluta e sorride perché lì si fa così, tutti ti salutano e sorridono.
“E perché sorridono sempre?”.
“Perché sono ospitali, gli americani. Sono aperti”.
Sono tipi simpatici, alla mano. E poi sono pratici: fanno sempre tutto che funziona bene e che è facile da usare. L’America è divertente, è confortevole. Ve ne abbiamo già parlato tante volte… Noi grandi ci siamo stati e ci è piaciuta tanto. L’abbiamo girata un bel po’, abbiamo visto posti bellissimi.
“Io non voglio vedere bei posti”.
“Ma sì, invece! Andremo a fare tanti viaggi”.
Vedremo la natura grande, grande che ti ci senti perso. Le strade lunghissime dove non incroci nessuno e ti senti libero. I motel dove non devi nemmeno scendere dalla macchina perché lo dicono già dalla strada se c’è posto e quanto costano, e sono dappertutto, non devi mai programmare niente. Tutto facile, in America… Vedrete.
Francesca Andreini Galanti

Dopo la laurea in Lingue e Letterature straniere moderne, lavora nella redazione di programmi televisivi, a Mediaset e a Telemontecarlo. Ha vissuto in Siria, in Senegal e a Washington DC. Ha pubblicato vari racconti e due romanzi: “Nessuno ti puo’ costringere” e “Primi anni a WDC”. Ha scritto per il teatro e il cinema e da oltre dieci anni collabora con la rivista letteraria online “Zibaldoni e altre meraviglie”. Dopo aver ideato e coordinato a Washington il Club ParoLab, per promuovere la letteratura italiana contemporanea in USA, è tornata a Roma, dove da quattro anni tiene laboratori di narrativa e cura gli eventi del circolo letterario Bel-Ami.
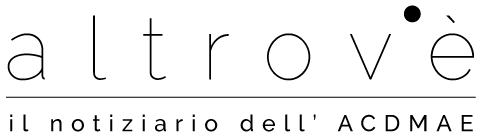
 VIA
VIA