di Francesca Andreini Galanti
Francesca Andreini inaugura una pagina dedicata alla poesia con due bei racconti.
Ospitare i suoi scritti sia la lieta sorpresa dell’Anno Nuovo e, dopo Francesca, attendiamo altri scrittori e altre storie!
Cari auguri a tutti Voi dalla Redazione di ALTROV’E!
È quasi Natale.
Non so bene come ci sono arrivata; mentre gli uragani si disperdevano devo aver perso un poco il senso del tempo…
A tornare in Italia non ci abbiamo pensato. Troppe spese, un gran trambusto. E ancora aspettavamo i vari responsi, la figlia era convalescente di un piccolo intervento… no, non abbiamo pensato a partire.
“Che bello, ci godremo un Natale bianco, alla maniera americana”.
“Con il caminetto acceso e la neve che fiocca”.
“Le canzoni di Natale e le decorazioni ovunque…”.
La famiglia intera è entusiasta all’idea di esplorare questa festività qui in America.
E scopriamo presto che si sprecano le une e le altre, la musica e le decorazioni, da queste parti.
La musica si ripete su ogni radio, in ogni locale pubblico, ti riecheggia in testa e ti ritrovi a fischiettarla tutto il giorno insieme ai vicini di casa, ai famigliari, agli amici. È un bombardamento di musiche tradizionali, sempre quelle, più un paio di canzoni recenti che, a forza di ascoltarle, ti diventano vecchie all’orecchio pure loro.
Non ne sono sicura, ma non mi sembra che in Italia sia così. Non avevo mai notato questa monotematicità in scelte musicali, dalle nostre parti. Qui è una vera ossessione. Sembra di vivere in un cartone animato di Walt Disney, dove Minnie e Topolino camminano fra strade addobbate e Jingle Bells li segue ovunque.
Poi ci sono le decorazioni, ovunque anche quelle. Non soltanto le luminarie pagate con una colletta fra i negozianti di una strada per vedere di attirare un po’ più di clienti come dalle nostre parti, no: una vera gara fra vicini a chi ha più lucine colorate appese sui cespugli, tutte bianche a pioggia dalle grondaie, come una distesa di lucciole sui tronchi spogli degli alberi e poi a forma di renna, di pacco regalo, di slitta… e fiocchi rossi enormi sulle porte, festoni di frasche sempreverdi sulle staccionate, perfino ghirlande appese ai cofani delle auto.
“Lo facciamo anche noi? Eh? Mettiamo anche noi le decorazioni?”.
“Ma certo!”.
Siamo rimasti apposta, per vivere la circostanza alla maniera di qui. E nei giorni a seguire ci adeguiamo ai costumi.
Il nostro albero di Natale, alto fino al soffitto (ma qui i soffitti sono tutti bassi, sui due metri e mezzo circa, quindi non un albero stratosferico) è così carico di palle, fiocchi e lampadine che alcuni rami cedono, piegandosi fino a terra in un tenero gesto di resa.
“Mi sa che le decorazioni sull’albero bastano…”.
“Ci vogliono quelle per fuori, adesso!”.
Non ci pensiamo neppure, a contrastare questo desiderio, anzi, ci affrettiamo ad assecondarlo. In parte per il brivido di adeguarsi, di connettersi a questi vicini coi giacconi imbottiti e i nasi rossi che ci osservano, mentre distribuiamo metrature esorbitanti di lucine in giardino, e ci lanciano saluti compiaciuti. Gli stessi che riceviamo quando facciamo giardinaggio, o i lanci con la palla da baseball, o laviamo l’auto. I passanti ci rivolgono questo entusiastico “Come stai?” che è come un riconoscimento, un sigillo: fai le mie stesse cose, amico, e quindi fai parte della mia stessa comunità; ti saluto e così facendo sancisco la nostra appartenenza comune a qualcosa di giusto.
Ma non è questo il motivo principale che ci ha spinti fuori, nel vento gelido, a intirizzirci le mani sui cespugli e le ringhiere, sotto una luce fioca che fatica a traversare gli strati grigiastri di un cielo uniforme e sempre più scuro.
È anche e sopratutto per quello strato nero che, ogni pomeriggio un po’ più presto, seppellisce in angoli lontani e invisibili anche gli oggetti più vicini. Vorresti metterti in testa una corona di candele e girare implorando alla luce di tornare, da queste parti, la sera.
Ma, da qualche tempo, mentre il buio ti formicola addosso un disagio che è quasi fastidio, in alcuni tratti delle strade lunghe e silenziose arriva il sollievo vivace delle luminarie del Natale. Alcune sono programmate per accendersi in automatico al calar del sole mentre altre si illuminano in momenti diversi, accese da vicini solerti. E sono piccoli punti di ristoro per gli occhi in cerca di qualcosa.
Adesso anche noi, quindi, vogliamo fare la nostra parte per alleviare il disagio dei viandanti.
Ci muoviamo in mezzo a un buio completo, con gli ultimi metri di luci in mano, e in fretta finiamo di sparpagliarli in percorsi imprevedibili. Poi attacchiamo la spina e ci beiamo del nostro lavoro, che crea un bell’effetto movimentato, un po’ anarchico. Chissà che ne penseranno gli altri? Magari a loro guardare la nostra opera d’arte farà l’effetto di prendersi un pugno in un occhio: le loro lucine seguono disegni schematici, tutti simmetrie e regolarità…
Sia che abbiano gradito, sia che si siano infastiditi, arrivano pochi giorni dopo, i vicini, a cantare le canzoncine di Natale. Suonano il campanello e appena apro la porta si mettono a suonare (un ragazzino con la tromba e un altro al sax) e cantare (bambini piccoli in un coretto da professionisti) alcuni classici del Natale. Gli stessi che circolano da settimane su tutte le radio, in tutti gli ambienti pubblici ecc. ecc.
Questa improvvisata mi inchioda, estatica, sulla soglia di casa. Stringendo le braccia per il freddo pungente, rapita dallo spettacolo.
Il cartone animato ha preso vita, si è incarnato nei nostri vicini e ci ha raggiunto, ci ha inglobato…
Poi mi riprendo e chiamo gli altri di casa a raccolta.
“Ehi, venite! Venite a vedere!”.
E arrivano subito le ragazze, con le facce curiose. Manca il piccolo che, mi spiegano, appena ha sentito suonare si è nascosto nell’angolo più nascosto del seminterrato.
Forse devo farlo esorcizzare…
Le sorelle ed io, e qualche minuto dopo anche il marito rincasato dal lavoro, ci godiamo lo spettacolo con stampata sulle facce un’espressione piena di vibrante felicità natalizia, amore per il prossimo, armonia con il vicinato.
I vicini, vedendo che gradiamo, continuano le loro canzoncine, una dopo l’altra. Proprio loro, i vicini così riservati, quelli che ci hanno sorpreso con il gesto dei biscottini all’inizio ma che poi si sono dileguati dietro le spesse barriere della riservatezza. Quelli che non fanno rumore, non li vedi e non li senti, hanno cinque figli ma non si vedono né si sentono e hai sempre paura di non stargli simpatico e di non essere capito e di non capirli. Loro, adesso, sono tutti lì, insieme ad un’altra vicina e un paio di figli di lei e, tutti insieme, sorridendo, suonando e cantando per te…
Vien naturale sbracciarsi subito, appena hanno finito, per farli accomodare dentro e mostrar loro il nostro albero, il nostro presepe. E quelli entrano tutti; un po’ rigidi e sulle punte ma entrano e si guardano intorno, e intonano un paio di altre canzoncine, già che ci sono. E, questa volta, anche noi lasciamo strabordare il nostro grato senso di amore natalizio in melodiche rincorse alle loro così ben confezionate performance.
È il momento di sciogliere l’atmosfera, di sedersi un attimo, bersi magari un bicchiere di qualcosa e guardarsi gioiosi e complici negli occhi. È l’epilogo felice in cui si sciolgono i ghiacci, si avvicinano i continenti e magari anche io riesco a fare amicizia con i vicini. Penso.
“Un prosecco? Una tazza di tè? Una fetta di panettone, un succo per i ragazzi?”.
Invece ecco il solito ritrarsi, il solito rinculare veloce, il solito sorridere ancora di più per dire che no, grazie, se ne stanno proprio andando.
“Sedetevi un momento, parliamo, accendo il camino…”.
“No grazie. Grazie molte”.
Chiudo la porta dietro la folata di illusioni che se ne va, insieme ai vicini musicanti, e mi stringo un attimo fra le braccia.
“Ho preso freddo…”.
“Che c’è da mangiare?”.
Questa figlia ha sempre fame. Una crescita poderosa, un gioioso appetito di vita, una ricerca regolare di cibo. La mando a stanare il fratello e vado a preparare.
“Ma dovrete aspettare, stasera abbiamo ospiti”.
Intanto rifletto su questo fatto: che io continuo a fraintendere, a più di un anno dal mio arrivo. Non sono ancora riuscita a distinguere, nel mio cervello si incontrano ancora e vanno a braccetto i riti di cortesia con il contatto umano. Che da queste parti, invece, son cose ben distinte.
I primi si sprecano e fanno da trama a tutti i comportamenti fondanti: dimostrarsi uniti, sentire la community e confermarsi l’un l’altro di essere americani, in sintonia con il paese e le regole. Il che ha il suo indiscutibile fascino: sentire così forti e così proprie le poche tradizioni che ti legano a tutti gli altri.
“Non me lo sarei mai aspettato, prima di vivere qui…” dico a tavola.
Spiego quanto mi stupisce che gli americani fra cui mi sono trovata ad abitare abbiano messo con così tanta cura le loro esistenze sul piccolo e solido perno delle tradizioni.
Questi momenti d’intesa collettiva, in cui si fa tutti esattamente la stessa cosa e con lo stesso spirito, gli appartengono proprio. Se li cercano, li rispettano, li vivono con fervente sollecitudine. Ogni festa comandata e la mattina di domenica in chiesa (di qualsiasi confessione si tratti), e poi i Barbecue della Scuola, i Travestimenti di Halloween, i Tacchini del Ringraziamento, le Luminarie del Natale….
Una gara fra vicini a chi esegue nel modo più corretto e più sentito le varie fasi del rito. Le decorazioni fuori, gli auguri giusti e con la giusta intonazione sparati a chiunque trovi per strada, l’abbigliamento, lo stato mentale e sopratutto gli acquisti… tutto si confà a questa intesa comune di essere d’accordo sul fare tutti insieme quella cosa.
Incredibile.
E fantastico, a modo suo.
“Di che farci una nazione che cresce e si impone, crede così tanto in se stessa da diventare un modello urbi et orbi”.
“Sì ma… non è che osservi questo perché vivi in un certo ambiente?”
Ribatte un commensale.
Ѐ vero. Noi tutti, in fondo, viviamo in questi quartieri molto bianchi, protestanti. Suburbi residenziali per famiglie che imperniano la propria esistenza su quanto di più bianco, protestante e famigliare ci sia. Compresa la voglia di vivere tutti stretti, in circolo, intorno al fuoco delle proprie tradizioni.
“Questo quartiere, poi, è così wasp… Lo sapete che fino a pochi decenni fa neppure gli Italiani erano graditi, da queste parti? E tutti i cattolici, in generale. E siccome ogni community, quando sorge, si dà le regole che vuole, questa qui aveva bandito italiani e cattolici dal suo terreno” racconta un invitato. “Poi però, in un moto di testardaggine tipicamente made in USA, un avvocato cattolico ha deciso che gli sarebbe piaciuto vivere proprio qui, per l’appunto; in questo quartiere”.
E siccome era americano, testardo, e anche avvocato, e siccome gli americani hanno questa straordinaria facoltà di creare delle situazioni incredibili e poi di saperle, incredibilmente, cancellare, l’avvocato cattolico e testardo ha vinto un paio di cause e quindi ha potuto comprare il suo appezzamento e costruirci la sua casa. E leggi successive, poi, hanno stabilito che regole dichiaratamente razziste contro una etnia o una religione non si potevano più fare. Aprendo la strada, in questo quartiere, a un infiltramento di cattolici e italiani che è proseguito, seppur contenuto, fino ad arrivare a noi.
“Che però,” dico io, “come gli altri italiani e cattolici che vivono qui, non disturbiamo le tradizioni”.
Siamo gente di mimesi, che viaggia e si adegua, rispetta, non impone usi e costumi diversi da quelli che trova. Il quartiere continua a vivere secondo i dettami più stretti delle tradizioni americane bianche, eterosessuali e protestanti.
Che sono poi quelle che, al di là e al di sopra delle infinite varianti di razza e cultura che si rimescolano in questo calderone, sono proprio quelle che si impongono nella collettività dei cervelli come “americane” sia per chi vive qui sia per chi le osserva dall’estero, attraverso le canzoni, la letteratura, i film.
“Sono diventate un modello per tutti. Le abbiamo incamerate ben bene”.
Prendiamo il Natale in Italia: in quale città non si addobba l’albero, non ci si inventano missioni impossibili di Babbo Natale, non si va in giro per febbrili acquisti? E poi, negli ultimi anni, quale città non ha messo su la sua pista per il ghiaccio, costruito enormi mall dove aggirarsi con consumistico sgomento, scoperto le decorazioni sulle facciate e i tormentoni alla White Christmas?
“Sì, però da noi è diverso. Facciamo le stesse cose, ma in modo diverso”.
Ribatte un ospite.
“È vero. Noi italiani i riti li viviamo ognuno per conto proprio…”.
Estendendoli, tutt’al più, alla famiglia; con le diverse varianti regionali, con i mugugni e le critiche che destano sempre in noi i momenti di impegno collettivo. Mentre per gli americani sono momenti in cui le collettività si ritrovano e si impegnano a fondo nel sentirsi, gioiosamente, comunità.
“Eh, le solite generalizzazioni,” rilancia un commensale, “l’America è anche la culla della contestazione. Prendete San Francisco, la patria dei movimenti alternativi. Il luogo che contraddice tutto questo perbenismo wasp…”.
Certo, San Francisco da decenni fende le acque placide del conformismo con ondate di pura ribellione, e scandalose virate fuori dagli schemi.
L’ho già vista tre volte, nel giro di venticinque anni, e ogni volta m’è parsa piccola e domestica; in contraddizione con tutto ciò che di enorme, vitale e glorioso hanno le altre città famose dell’America.
Fra le colline che salgono e scendono in una specie di luna park urbano, i piccoli tram su rotaia tagliano quartieri ben definiti, divisi per tradizioni: quello italiano, quello cinese, quello del porto, quello hippy.
“Non c’è una casa uguale all’altra, non un colore in tono con l’altro”.
Vero anche questo. Forme e vernici sembra facciano a gara a chi riesce a essere più diverso. Come fra le casette antiche, affiancate l’una all’altra con i loro portoni vivaci, con gli stipiti lavorati e le grondaie decorate, con i piccoli scalini che portano all’entrata affiancati da ringhiere le più varie.
E perfino nelle parti esotiche come le strade dei cinesi, dove decorazioni di stucchi dorati e rossi, lanterne, draghi, coprono ovunque le facciate. Come se l’arredamento di quello che per noi è un ristorante cinese un po’ kitch, un po’ acchiappacitrulli, fosse esploso, coprendo le vie di oggetti strabilianti.
E poi fra i residuati degli anni settanta, lungo le sfilze di negozi che mettono foga e gusto a stupire con i gadget più strampalati: parrucche di tutti i colori, abiti usati di ogni epoca, costumi di ogni tipo, libri inediti, chilum di ogni foggia, tatuaggi, perle in vinile…
Ovunque è tutta una gara per raggiungere la meta dell’originalità.
“A parte l’imbarazzo di spiegare l’utilizzo di alcuni oggetti in vetrina ai ragazzi, però, non è che mi dessero molte emozioni. Erano gli stessi negozi di tanti anni fa, ma più opachi, con gente più spenta dentro…”.
“E gli hippy? Ci sono ancora gli hippy?”.
“No, l’ultima volta che l’ho visitata, questa estate, non c’erano più”.
Del movimento in cui tutti si sentivano liberi come l’aria e più ottimisti della Dorothy de Il mago di Oz rimane solo qualche pulmino Volkswagen dipinto di fiori, qua e là.
Il movimento di canzoni e tinte forti, sogni chimici, amore universale si è dissolto, è svaporato. Ha costruito niente, ha spennellato di colore queste strade e qualche canzone. Riecheggia in anfratti di cuore di chi l’ha intravisto e ne ha preso di schiso l’onda d’urto. Ha visto i fratelli più grandi partire con lo zaino in groppa e attraversare l’America a piedi, su mezzi di fortuna, fermandosi in case dove tutto era in comune e suonando canzoni su chitarre che erano costate tutti i soldi rimasti. Tutto facile, permesso, possibile. Deve essere stata una potente allucinazione collettiva. Un intestardirsi a vivere nella fantasia, come aggrapparsi a un sogno piacevole prima della veglia.
Gli abitanti di San Francisco stanno a occhi chiusi e pugni stretti, si muovono ancora nel sogno che vive fuori dagli schemi e contro il sistema.
Nella realtà di quel che resta del sogno c’è la voglia di distinguersi, di non intrupparsi, di pensare secondo coscienza e natura. Tutti: dal primo all’ultimo.
Del resto, come potrebbe essere diversamente?
“Se ci pensate bene, i benpensanti conservatori sono banditi Da San Francisco come i freak lo sono dai sobborghi di Bethesda”.
La ribellione collettiva… In fondo anche questo di stupire e stare fuori dagli schemi è diventato uno standard.
“Mutando quel che c’è da mutare, anche a San Francisco la regola americana non si smentisce. Sempre tutti adeguati, anche lì. Tutti a rendere omaggio al rito collettivo di turno, che in questo caso è l’originalità”.
Francesca Andreini Galanti

FRANCESCA ANDREINI è nata a Firenze, dove ha studiato Lingue e Letterature straniere moderne. Dopo la laurea si è trasferita a Roma, dove ha lavorato nella redazione di programmi televisivi per Mediaset e Telemontecarlo. Ha vissuto in Siria, in Senegal e a Washington DC. Parla inglese, francese e spagnolo. E riesce a fare due (proprio due) chiacchiere in arabo e tedesco.
È scrittrice di narrativa (“Il mercato di Awa”, racconto, finalista premio Teramo 2005; “Gino” , romanzo, uscito a puntate su ‘Zibaldoni e altre meraviglie’ fra 2004 e 2006; “Nessuno ti può costringere”, romanzo, pubblicato da QuiEdit nel 2009; “Cronache Americane”, romanzo, pubblicato a puntate su Zibaldoni fra 2010 e 2012 e come e-book nel 2014).
Ha scritto anche per il teatro (“Impara l’arte”, commedia, finalista alla XIII edizione del Premio Enrico Maria Salerno per la drammaturgia europea) e il cinema (“Senza me”, sceneggiatura, riconosciuta di interesse culturale con contributo statale opere prime e seconde del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2010).
Fra il 2012 e il 2014 ha coordinato ParoLab, un club di Washington che promuove la letteratura italiana contemporanea negli Stati Uniti.
Attualmente vive e lavora a Roma, dove è socia del circolo letterario Bel-Ami per il quale cura il laboratorio di narrativa Martedì prosaici. Per la rivista letteraria on line Zibaldoni e altre meraviglie, con cui collabora da oltre dieci anni, tiene la rubrica “Le prime volte”.
È sposata con Lorenzo e ha tre meravigliosi figli.
Ancora notizie e racconti di Francesca Andreini su: www.francesca-andreini.com
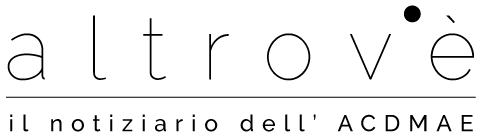

Frequento il corso di scrittura narrativa che Francesca Andreini tiene in via Quattro Fontane (sul sito di Francesca ci sono tutte le indicazioni). Lei è preparatissima, stimolante, chiara e …trascinante! Una vera miniera di idee e ispirazione! Il gruppo che la segue è interessante e simpatico. E poi, a fine incontro, si cena insieme e si beve un buon bicchiere di vino parlando di letteratura e poesia.
Insomma: torno a casa con il cuore che canta!
Grazie Francesca per le tue parole bellissime, dette e scritte!
Eleonora